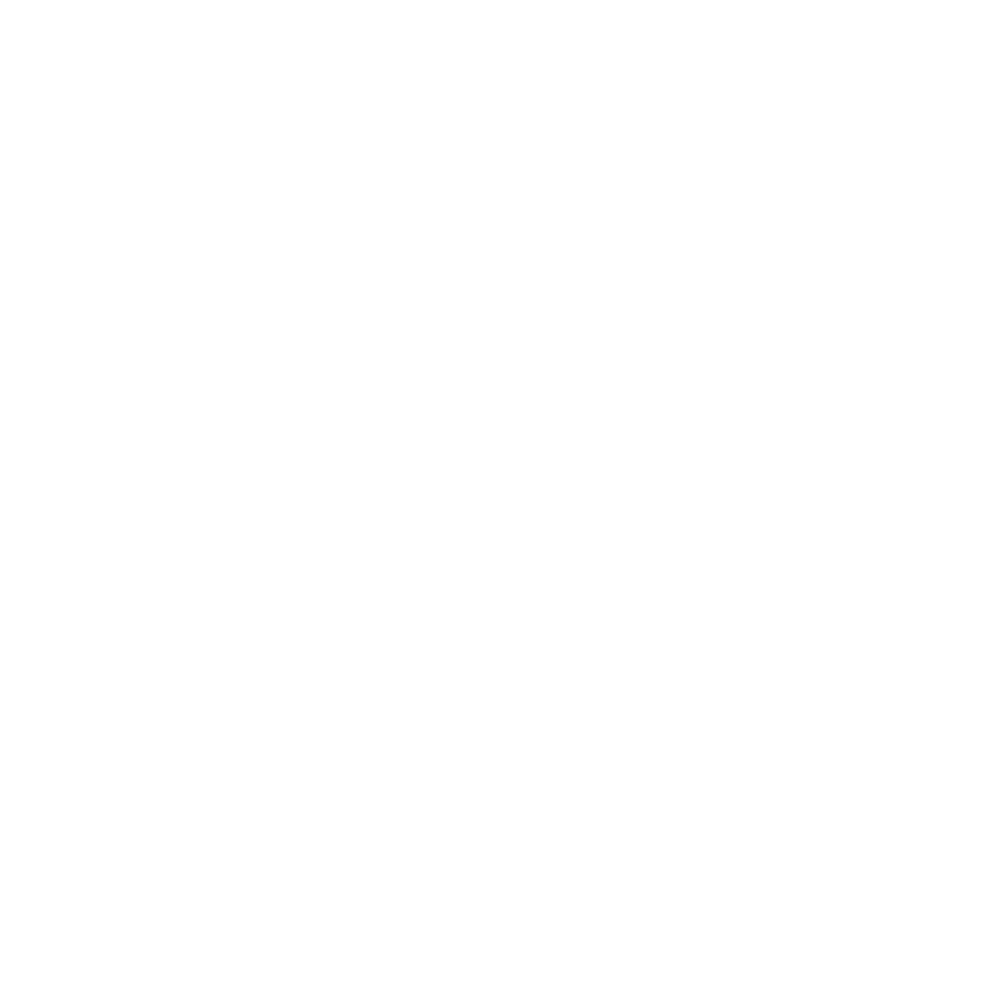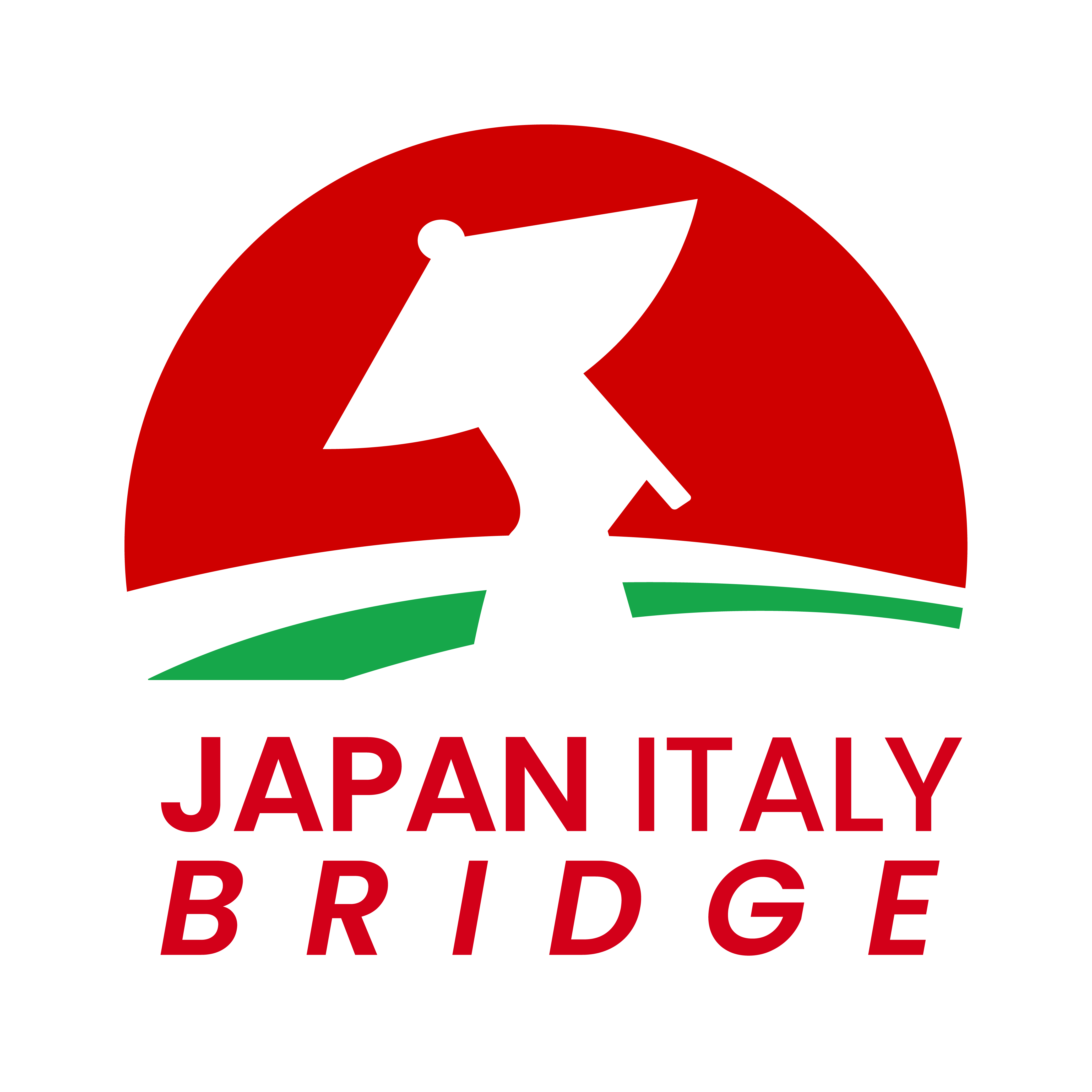Japan Folklore: Tennin
Tennin

Photo credits: google.it
Le radici del Buddhismo in Giappone sono molto profonde e seguono di pari passo la storia del paese, evolvendosi con esso. Il Buddhismo giapponese infatti è costituito in buona parte dalla continuazione o dall'evoluzione delle antiche scuole del Buddhismo cinese. Alcune di queste scuole oggi estinte nel paese d'origine, introdotte nell'arcipelago nipponico in epoche diverse hanno qui continuato a vivere e a mutare.
Inoltre, l'introduzione della scrittura e della cultura cinesi, che sono all'origine della Storia del Giappone propriamente detta (VI secolo) fu veicolata anche da rapporti di carattere religioso. I monaci buddhisti rimarranno per lungo tempo i tramiti e gli interpreti più importanti della cultura continentale in Giappone.
Le Creature Celestiali
Quando si parla di Buddhismo, siamo portati a pensare immediatamente a Buddha. In realtà ci sono figure molto importanti affiancate a Buddha che risiedono assieme a lui nel paradiso buddhista. Tra queste figure troviamo i Tennin, frutto anch’essi di un lungo processo di assimilazione e trasformazione.
I Tennin , il cui nome è composto dai kanji 天 che significa cielo e 人 persona, sono letteralmente "creature celestiali", esseri spirituali. Essi comprendono gli HITEN 飛天, le creature volanti, gli UCHUU KUYOU BOSATSU 雲中供養菩薩, Bodhisattva seduti su delle nuvole, le TENNYO 天女, le fanciulle celestiali, i TENNOTSUKAI 天の使い, i messaggeri celesti e i KARYŌBINGA 迦陵頻伽, i quali sono assistenti celestiali che appaiono in varie forme, ma solitamente sono creature con il corpo di uccello e la di un Bodhisattva.

Photo credits: google.it
Costoro non sono oggetti di culto, anche se la gente accorda loro una certa venerazione mettendo fiori, acqua e riso ai loro piedi. La loro funzione è quella di proteggere la legge buddista servendo il DEVA ovvero il gruppo TENBU, divinità che includono esseri divini e creature soprannaturali come il Drago, l'uomo-uccello Karura e le Ninfe Celestiali.
La maggior parte ha origine nelle precedenti tradizioni vediche dell'India. Il termine sanscrito per questi esseri celesti è Apsara, ed esso si riferisce alle bellezze divine e ai ballerini che popolavano la corte di Lord Indra nella mitologia indù. In Giappone, il termine Apsara è reso come TENNIN.
Nell'arte, appaiono più frequentemente come ballerini e musicisti che adornano statue, dipinti e templi in Cina, Giappone e Sud-Est asiatico. I loro attributi non sono chiaramente specificati nei testi buddisti e quindi il loro aspetto è piuttosto vario. In Giappone, vengono spesso mostrati in piedi o seduti sulle nuvole o mentre volano in aria in pose aggraziate. Spesso sono intenti a suonare strumenti musicali o a spargere fiori per lodare gli dei, e di solito indossano indumenti celesti leggeri e fluttuanti, impreziositi da sciarpe di garza, i Tenne.
Japan History: Hattori Hanzō
Hattori Hanzō
Hattori Hanzō (服部 半蔵, ~1542 – 4 Novembre, 1596), conosciuto anche come Hattori Masanari o Hattori Masashige (服部 正成), è stato un samurai dell'era Sengoku. È famoso per aver salvato la vita di Tokugawa Ieyasu e per averlo aiutato a diventare il dominatore del Giappone.

Photo Credits: wonderslist.com/
Era il figlio di Hattori Hanzō Yasunaga (服部 半蔵(半三) 保長), samurai minore al servizio del clan Matsudaira (successivamente Tokugawa). In seguito, per via delle tattiche utilizzate per le sue operazioni, gli venne dato il soprannome di Oni no Hanzō (鬼の半蔵, Demone Hanzō). Ciò per distinguerlo da Watanabe Hanzo (Watanabe Moritsuna), il cui soprannome era Yari no Hanzō (槍の半蔵 Lancia Hanzō).
Si narra che Hanzō iniziò il suo addestramento sul monte Kurama a nord di Kyōto all'età di 8 anni, divenne un guerriero esperto a 12 anni e fu riconosciuto come maestro samurai a 18.
Combattè la sua prima battaglia a 16 anni (un attacco notturno al Castello di Udo). Successivamente, riuscì a portare a termine con successo il salvataggio delle figlie di Tokugawa al Castello di Kaminogō, nel 1562, prendendo poi d'assedio il Castello di Kakegawa nel 1569.
Si distinse inoltre nelle battaglie di Anegawa (1570) e Mikatagahara (1572).
Secondo il Kansei Chōshū Shokafu, una genealogia di grandi samurai completata nel 1812 dallo shogunato Tokugawa, Hattori Hanzō rese meritevole servizio a Mikatagahara, diventando poi comandante dell'Unità di Iga costituita da 150 uomini. Catturò infatti una spia di Takeda Shingen chiamata Chikuan e, quando le truppe di Takeda invasero Totomi, Hanzō contrattaccò con soli 30 uomini presso il fiume Tenryū.
Durante la guerra Tenshō Iga, nel 1579, difese il paese natale dei ninja nella provincia di Iga dalle mire di Oda Nobukatsu, secondo figlio di Oda Nobunaga. E di nuovo combattè valorosamente nel 1581, questa volta però senza successo, per prevenire che la provincia di Iga venisse eliminata dalle forze sotto il comando personale dello stesso Nobunaga.
Il suo più grande contributo arrivò però nel 1582, dopo la morte di Oda Nobunaga. Guidò infatti il futuro shogun Tokugawa Ieyasu verso la salvezza, nella Provincia di Mikawa, attraversando il territorio di Iga con l'aiuto dei rimanenti ninja locali. Hanzō sembra abbia anche aiutato a salvare la famiglia di Ieyasu che era stata catturata.
Prestò servizio durante l'assedio di Odawara e fu premiato con 8,000 koku. E nel momento in cui Ieyasu entrò Kantō, ricevette altri 8,000 koku, 30 yoriki e 200 pubblici ufficiali a suo servizio. Si diceva inoltre che Ieyasu avesse cominciato a assumere al suo servizio più ninja di Iga con Hanzō come leader.
Hanzō era famoso per essere un esperto stratega e maestro nella lotta con la lancia. Fonti storiche dicono che trascorse gran parte dei suoi ultimi anni come monaco sotto il nome di "Sainen", e che avesse costruito il tempio Sainenji. Tempio eretto per commemorare il figlio maggiore di Tokugawa Ieyasu, Nobuyasu. Nobuyasu infatti era stato accusato di tradimento e di cospirazione da Oda Nobunaga e gli era stato ordinato di fare seppuku da suo padre Ieyasu. Hanzo fu chiamato come suo secondo ufficiale per mettere fine alle sofferenze di Nobuyasu. Ruolo che rifiutò non volendo sollevare la spada sulla discendenza del suo stesso signore. Sembra che Ieyasu, dopo aver saputo delle traversie affrontate da Hanzo, avesse apprezzato la sua lealtà e disse: "Anche un demone può versare lacrime".
Alcuni racconti gli attribuiscono abilità sovrannaturali come il teletrasporto, la psicocinesi, e la precognizione. Tutto ciò ha contribuito a renderlo sempre più importante nella cultura popolare. Morì all'età di 55 anni.
Dopo la sua morte, il 4 Novembre 1596, a succedergli fu suo figlio, il cui nome era sempre Masanari scritto però con kanji differenti. Ricevette il titolo di Iwami no Kami ed i suoi uomini di Iga furono posti a guardia del Castello di Edo, il quartier generale del governo del riunito Giappone. Ad oggi, è ancora possibile vedere una parte dell'eredità lasciata da Hanzō. Il Palazzo Imperiale di Tokyo ha ancora un cancello chiamato Hanzō's Gate (Hanzōmon), con una omonima linea metropolitana Hanzōmon.
Hattori Hanzō nella cultura di massa

Photo Credits: bastardosenzagloria.com
Come figura storica e protagonista di uno dei più grandi periodi della cultura dei samurai in Giappone, Hattori Hanzō ha molti ammiratori, sia Giapponesi che non. Nella cultura moderna è spesso associato ai ninja di Iga.
Molti film, speciali e serie tv sulla vita di Tokugawa Ieyasu descrivono gli avvenimenti menzionati sopra. L'attore Sonny Chiba ha interpretato il suo ruolo nella serie Hattori Hanzô: Kage no Gundan (Guerrieri dell'ombra), in cui lui e i suoi discendenti sono i personaggi principali.
La sua vita ed il servizio reso a Tokugawa Ieyasu sono stati ripresi nella manga Path of the Assassin, mentre il giovane Hanzō è il personaggio principale del manga Tenka Musō.
Il romanzo The Kouga Ninja Scrolls ed i suoi adattamenti ritraggono i 4 Hattori Hanzo che hanno servito come capi ninja sotto il comando di Tokugawa Ieyasu.
Hanzō appare anche nel romanzo Fukurō no Shiro (Owl's Castle), nonché in tutta una serie di manga. Nel manga ed anime Gintama ad esempio è presente un personaggio parodia chiamato Hattori Zenzo, mentre nel manga Naruto il personaggio chiamato Hanzō è il leader del villaggio segreto di ninja Amegakure. In Samurai Deeper Kyo, un inusuale colpo di scena rivela che Hattori Hanzō è in realtà Tokugawa Ieyasu travestito. Compare anche in Tail of the Moon, e nel live-action Goemon, oltre che nell'episodio "Spartan vs. Ninja" del programma televisivo Deadliest Warrior.
Hattori Hanzō appare come un personaggio ricorrente nella serie di video game Samurai Shodown della SNK, apparendo in ogni gioco della serie, nonché nell'adattamento anime. Fa alcune comparse anche nella serie The King of Fighters. In World Heroes, un altro videogame della SNK, Hanzō è uno dei personaggi principali insieme al suo rivale Fūma Kotarō. Nel video game Samurai Warriors è invece ritratto come un ninja altamente qualificato, molto leale a Tokugawa Ieyasu. Appare anche in diversi altri video game come Taikou Risshiden V, Kessen III, Civilization IV: Beyond the Sword, Shall We Date?: Ninja Love, Pokémon Conquest, Sengoku Basara: Samurai Heroes, e la serie Suikoden. Nell’edizione limitata di Total War: Shogun 2 è il capo del Clan Hattori, una delle fazioni che lottano per la supremazia in Giappone, e ha una unità DLC chiamata"Hanzo's Shadows".
Alcuni lavori, come il gioco di carte collezionabili Force of Will, la serie Hyakka Ryōran, l'anime Sengoku Otome: Momoiro Paradox, ed il video game Yatagarasu, lo reimmaginano come ninja donna.
Nel film Kill Bill, Hattori Hanzō è il nome di un abilissimo maestro forgiatore di letali spade che ha creato una katana speciale per la protagonista, nonostante avesse giurato a sè stesso che non avrebbe più realizzato strumenti di morte.
Japan Modern Culture: Kimi no Na wa - Your Name
Kimi no Na wa - Your Name

Photo credits: Tumblr.com
Your name (titolo originale: 君の名は。- Kimi no Na wa.) è il fortunato film d'animazione giapponese diretto da Makoto Shinkai e prodotto dalla CoMix Wave Films. Tra il 2016, anno di rilascio, e il 2017 ha sbancato i botteghini non solo in Giappone ma in tutto il mondo.
L’opera ha i tratti di una storia d'amore adolescenziale, ma anche del thriller fantascientifico intriso di riferimenti alle tradizioni e alla cultura giapponese. Con continui cambi di prospettiva e balzi temporali, una animazione vivida e avvolgente, una colonna sonora che accompagna le scene e ne sottolinea i dettagli, Your name ha saputo conquistare milioni di fan.
La Storia

Photo credits: www.zerochan.net
Il centro della storia sono due ragazzi delle scuole superiori, Mitsuha Miyamizu e Taki Tachibana.
Mitsuha vive nel piccolo villaggio montano di Itomori nei pressi di Tokyo e ama passare il suo tempo con i suoi due amici Sayaka e Tessie. Ha una sorella più piccola e un padre, politico locale, che sembra essere poco interessato a loro. La madre invece è morta e le due sorelle vivono con la loro nonna. Mitsuha, come la nonna, è destinata a diventare una miko, sacerdotessa del tempio locale di cui la sua famiglia è custode. Ma è una vita che le sta stretta, oltre a causarle un pò di imbarazzo con i compagni. Ciò che desidera è trasferirsi nella sfavillante metropoli e vivere come una ragazza normale, anzi di essere nella prossima vita un bel ragazzo di Tokyo.
Taki invece vive proprio nel centro di Tokyo e conduce una vita normale divisa tra scuola, amici e il suo lavoro part-time. Nel tempo libero infatti fa il cameriere in un ristorante italiano, Il giardino delle parole, nome che è un chiaro riferimento ad una precedente opera di Shinkai. E' un ragazzo un pò irruento ma in fondo gentile che aspira a diventare architetto. Come gli altri colleghi di lavoro, è innamorato della bella collega Miki Okudera.
Un giorno però, la vita dei due protagonisti, che vivono senza sapere dell'esistenza l'uno dell'altra, viene sconvolta da qualcosa di impensabile. In quella che sembrava una mattina come tutte le altre i due si ritrovano, senza una spiegazione plausibile, a scambiarsi di corpo. Questi scambi continueranno per diverso tempo tanto che, superata l'iniziale sorpresa, i due cercano di adattarsi alla nuova condizione. Comunicando soprattutto tramite un diario sui rispettivi cellulari in un certo senso si aiuteranno a vicenda. Mitsuha, con il suo lato dolce e affabile, aiuterà Taki ad avere un appuntamento con la collega di cui è innamorato. Taki invece, con il suo temperamento, aiuterà Mitsuha ad affrontare i suoi compagni di scuola e ad essere più sicura di se. Non ci vorrà molto perché i due, pur non essendosi mai incontrati, comincino a provare qualcosa l’uno per l’altra.

Photo credits: twitter.com
Un giorno Mitsuha racconta a Taki di una cometa che passerà sui cieli del Giappone proprio nel giorno del suo appuntamento con la bella Okudera. Ad Itomori è il giorno della festa d'autunno. Il ragazzo non capisce di cosa parli ma quando cerca per la prima volta di chiamare il cellulare di Mitsuha, il suo tentativo fallisce. Capisce che per loro non è più possibile scambiarsi i corpi e decide quindi di andare ad incontrarla di persona.
Quando finalmente scopre il nome del villaggio, scopre anche che era stato distrutto tre anni prima. Un frammento della cometa Tiamat era precipitato su Itomori, distruggendo quasi completamente il villaggio ed uccidendo un terzo degli abitanti, tra i quali anche Mitsuha.
Taki si reca allora al santuario del dio protettore locale, Musubi, sulla cima del monte Hida poco fuori dal villaggio. Dopo essere entrato nel luogo sacro decide di bere il Kuchikamizake, il sake preparato da Mitsuha e che lui stesso, nei panni di lei, aveva lasciato lì come offerta trovandosi di fatto a viaggiare indietro nel tempo. Rivede il passato di Mitsuha e si risveglia ancora una volta nel corpo della ragazza, poco prima della caduta della cometa. Consapevole di ciò che accadrà Taki fa di tutto per far si che gli abitanti del villaggio si rendano conto del pericolo. Ma sa anche che quella è la sua ultima occasione per vedere Mitsuha. Corre quindi ad incontrare la ragazza in cima al monte Hida, dove il suo corpo del futuro era rimasto. Qui, i due protagonisti riescono a vedersi, per pochi istanti, prima che le loro memorie vengano cancellate. L’impegno dei due giovani salva il villaggio cambiando così il corso della storia, ma allo stesso tempo lascia in loro un senso di vuoto. Questo distacco da qualcosa a cui non sanno dare né un nome né un volto li spinge a cercarsi pur non avendo più memoria l’uno dell’altra.
Il Successo

Photo credits: one--anime.blogspot.it
Il film, proiettato in anteprima nel luglio 2016 in occasione dell'Anime Expo di Los Angeles, è stato poi distribuito nelle sale cinematografiche Giapponesi a partire da agosto. Da subito acclamato come un capolavoro, nella sua marcia trionfale ha attraversato ben 92 paesi incassando più di 355 milioni di dollari. Questo lo rende il primo anime per numero di incassi nella storia. Un traguardo che nemmeno gli autori stessi si aspettavano di raggiungere.
Questo successo commerciale lo ha reso il secondo film di animazione di maggior successo in patria dopo la Città incantata di Hayao Miyazaki. È in oltre il quarto film più visto secondo solo a Titanic e Frozen. Ma si è anche guadagnato la posizione di film di animazione giapponese più visto in diversi altri paesi del mondo.
Per quanto riguarda l’Italia, il primo trailer in lingua italiana è stato trasmesso solo dal 6 dicembre 2016. Successivamente, il film è stato proiettato in circa 160 sale dal 23 al 25 gennaio 2017 grazie a una collaborazione fra Dynit e Nexo Digital. Il successo di incassi è stato tale che ne sono state fatte diverse repliche, con un incasso totale è stato di circa 700.000 euro.
A guardare questi numeri non stupisce che il direttore Shinkai sia stato definito da alcuni come il successore di Hayao Miyazaki. Titolo che l’interessato ha molto umilmente rifiutato affermato di non esserne all'altezza
Temi e Simbologia

Photo credits: instarix.com
L'ispirazione per la storia è arrivata all'autore da opere quali Inside Mari di Shūzō Oshimi o Ranma ½, così come anche da opere classiche come il Torikaebaya Monogatari risalente al periodo Heian (794 - 1185). Ma un'altra fonte di ispirazione per l'autore pare essere stato un antico poema della poetessa Ono no Komachi, che visse tra l’800 e il 900.
In una sua poesia la donna scrisse : "Forse ero assorta in pensieri d'amore quando chiusi gli occhi? Lui comparve. Se avessi saputo che era un sogno non mi sarei svegliata."
E in effetti più che scambiarsi di corpo i due protagonisti di Your name sognano l’uno dell’altra. Ciò è possibile perchè Mitsuha è una sacerdotessa devota al dio Musubi, la divinità che governa le esperienze e le connessioni umane. Quando Taki nel corpo di Mitsuha si rivela alla nonna, l’anziana donna non ne sembra sconvolta, anzi. Lei stessa infatti ne aveva avuto esperienza trattandosi di un particolare potere della famiglia, pur non ricordando più il ragazzo nei suoi sogni.

Photo credits: forum.gamer.com.tw
Il tempio, situato in cima ad una montagna che sembra essere il cratere di una precedente apparizione della cometa, rappresenta un luogo sacro. Rappresenta il confine tra il regno degli dei e quello terreno, tra il regno dei vivi e quello dei morti. Per entrarvi, bisogna lasciare una parte di sé, e Mitsuha lascerà una parte di sè nel sake da lei preparato. La creazione del Kuchikamizake è una tradizione di famiglia Miyamizu, assieme alle danze tradizionali e all'intreccio dei fili. È un particolare metodo di creazione del sake che prevede la masticazione del riso per attivarne la fermentazione.
Sono molto importanti a questo proposito le parole pronunciate dalla nonna di Mitsuha:
“Musubi, è l’antico nome del dio guardiano di questi luoghi.
Intrecciare i fili è Musubi.
Il legame tra le persone è Musubi.
Lo scorrere del tempo è Musubi
Tutto questo è parte del potere della divinità.
I fili intrecciati che fabbrichiamo sono un dono della divinità e rappresentano lo scorrere del tempo stesso.
Essi convergono e prendono forma. Si curvano, si intrecciano. A volte si sciolgono, si rompono, e poi si riconnettono di nuovo.
Questo è Musubi. Questo è il tempo.
Musubi è anche condividere qualcosa con qualcuno.”
Queste parole, oltre a rappresentare un concetto spirituale molto profondo, rendono anche la forza del gesto compiuto da Taki quando beve il sake preparato da Mitsuha. Questo gesto infatti è un atto simbolico di connessione profonda in cui il giovane assume in sé una parte di Mitsuha e del suo potere spirituale permettendogli così di incontrarsi.

Photo credits: fakemorisummer.wordpress.com
Altrettanto simbolico è il fatto che i due giovani si incontrino al tramonto. Secondo le antiche leggende infatti, il tramonto è il momento in cui il confine tra il mondo degli spiriti e quello terreno si fa più labile. Ed è per questo che i giovani possono finalmente incontrarsi pur essendo Mitsuha morta 3 anni prima. I due dovendo però sacrificare i loro ricordi per poter tornare nel mondo terreno.
Un’altra leggenda giapponese trova spazio nella storia. Taki e Mitsuha sembrano infatti essere altresì legati da quello che molti conoscono come il ‘filo rosso del destino’ che si dice leghi due persone destinate a stare insieme. Filo rosso simboleggiato in questo caso da un laccetto che la stessa Mitsuha aveva realizzato e poi donato a Taki.
Shinkai, che come abbiamo detto non si aspettava il successo di pubblico planetario, ha affermato che era nelle suo intenzioni creare un film che avesse come target i giovani giapponesi. Voleva creare qualcosa che li spingesse a credere nel loro futuro.
Lui stesso ha detto: "Ho creato questo film sperando che il pubblico giovane potesse credere nel fatto che 'forse c'è quel qualcuno nella mia vita che magari non ho ancora incontrato, ma che potrei incontrare domani, o in futuro.' "

Photo credits: www.amazon.co.jp
Un altro tema importante affrontato dal film è quello della giustapposizione tra la piccola città rurale e la grande metropoli Tokyo, qualcosa che l'autore stesso ha sperimentato. Cresciuto infatti in un piccolo villaggio, si è poi trasferito a Tokyo, cosa che accomuna molti giovani giapponesi.
Qui vediamo Mitsuha, vive immersa nelle tradizioni locali, ma desidera la vita di città, mentre Taki, immerso nella vita di città, impara ad apprezzare il passato e le tradizioni.
Ancora una volta sono le parole della nonna a venirci in aiuto: "Anche se le parole sono andate perdute è importante mantenere le tradizioni ". Con questo sembra volerci ricordare da dove veniamo, contrapponendosi al figlio, politico locale corrotto, che ha scelto di abbandonare completamente il tempio.
Le antiche tradizioni rappresentano il sostrato fondante della comunità, ciò su cui il presente si basa e che lega tutte le persone insieme. E quello che le rende capaci di affrontare anche i periodi più bui.
Il giappone non è estraneo ai disastri naturali, basti ricordare il recente terremoto del 2011, o il grande terremoto del Kanto del 1923. E come dimenticare il disastro atomico che pose fine alla seconda guerra mondiale. Da tutto questo, il Giappone ha sempre trovato il modo di ripartire, ponendo un interesse sopra gli altri: come impedire che ciò che è accaduto una volta accada ancora. Non c'è da stupirsi allora che in questo film i due protagonisti cerchino di impedire quello che sarebbe una vera e propria tragedia.
L'obiettivo del film è quello di dare speranza, ma invita anche a non dimenticare mai le proprie radici e l'unione spirituale che esse possono creare.
Potremmo affermare quindi che Your name abbia una funzione quasi catartica per chi lo guarda.
Punti di Forza

Photo credits: Lovejude
Che siate tra coloro a cui il film è piaciuto o meno, Your Name ha sicuramente diversi punti di forza oggettivi.
Primo fra tutti l'animazione e la resa molto realistica delle ambientazioni, come è nello stile dell'autore del resto. I paesaggi sono descritti nei minimi dettagli e i colori sono caldi e brillanti. Le immagini sono così vivide da trasmettere, anche solo con i loro colori, le emozioni vive e pure dei protagonisti, contribuendo quindi alla funzione catartica del film.
Pregevole è anche la colonna sonora che è stata composta dal vocalist della rock band giapponese Radwimps, Yojiro Noda.
A Noda, caldamente voluto dallo stesso Shinkai, è stata fatta una sola richiesta : “fare in modo che la musica fosse un complemento al dialogo o al monologo dei personaggi".
E considerati i risultati possiamo dire che proprio questa colonna sonora rappresenti una delle chiavi del successo di questo film.
Questo mondo sembra volermi tenere buono
Come desideri allora, io mi dibatterò splendidamente.
Your Name Theme song - Yojiro Noda
Eppure, nonostante le critiche positive, Shinkai ha affermato che il film è in realtà non è così riuscito come lo aveva pensato. La mancanza di tempo e di fondi lo hanno costretto a consegnare al pubblico un opera che lui stesso definisce incompleta.
Ha infatti affermato : "Ci sono cose che non abbiamo potuto fare, Masashi Ando (direttore dell’animazione) avrebbe voluto continuare a lavorarci ma ci siamo dovuti fermare per mancanza di tempo e soldi…. Per me è un lavoro incompleto, sbilanciato. La trama va bene ma non è perfetta. Due anni non sono stati sufficienti."
Prodotti correlati e remake

Photo credits: Amazon.co.jp
Oltre al film, i prodotti correlati a Your Name comprendono altre opere, tra un romanzo, manga, guide al film e cd. Nel solo mese di dicembre 2016, le vendite di questi prodotti sono ammontate a circa 2,5 milioni di copie.
Il romanzo e il manga omonimi in italia sono editi dalla casa editrice J-Pop. Il film in versione Blu-ray e DVD normale, rilasciato nel luglio 2016, è arrivato in Italia nel novembre 2017.
Le vendite hanno confermato il successo delle sale cinematografiche.
Lo scorso settembre è stato anche annunciato che Kimi no na wa avrà presto un adattamento cinematografico hollywoodiano.
Il produttore scelto altri non è che J.J. Abrams (Star Trek, Mission impossible). L'annuncio ha già scatenato i molti fan del film ma anche i semplici curiosi. Molte sono le voci preoccupate che questo adattamento possa stravolgere quello che a tutti gli effetti viene considerato un capolavoro.
E i precedenti non sembrano giocare a favore di questo live action. E’ ancora recente la notizia che il direttore del remake Netflix di Death Note abbia dovuto chiudere il suo account Twitter dopo essere stato attaccato duramente per il lavoro svolto. Duri attacchi sono stati riservati anche ad un altra opera di animazione molto amata, Ghost in the shell, il cui film con Scarlett Johansson non ha proprio soddisfatto i fan.
Kimi no na wa certo non è un film semplice da adattare in ambientazione occidentale per via dei suoi numerosi richiami a particolari ambientazioni e a particolari riferimenti culturali e religiosi. Si pensi a Mitsuha e alla sua famiglia, custodi del tempio del dio Musubi e delle antiche tradizioni del villaggio.
Per quanto riguarda i luoghi invece, oltre ad Itomori che è un villaggio di fantasia, ci sono delle città reali. Non solo Tokyo, ma anche Hida, e lo stesso lago di Itomori è ispirato ad un famoso lago giapponese, il lago Suwa.
Solo il tempo ci dirà quale sarà il futuro di questo adattamento.
Trailer italiano:
Japan Folklore: Tradizioni Natalizie
Tradizioni Natalizie
Photo credits: Inside Japan Tours
Meri Kurisumasu!
In Giapponese “Buon Natale” si dice “Meri Kurisumasu” ed è scritto sia in Hiragana (めりーくりすます) che in Katakana (メリークリスマス). Babbo Natale è invece conosciuto come Santa-san (サンタさん、サンタクロース), importato direttamente dagli USA dove il pacioccone signore vestito di rosso è chiamato proprio Santa Claus.
Esiste però anche in Giappone una figura molto simile a Babbo Natale anche se non strettamente legata al Natale. È Hotei-osho, un dio Giapponese della buona fortuna nella tradizione buddista, e anch’egli è solito portare doni.
Il Natale non è considerato come festa nazionale ma trovandosi tra il 23 dicembre, giorno del compleanno dell’attuale Imperatore Akihito, ed il 31 dicembre, spesso le scuole sono chiuse per il 25 dicembre. È considerato invece un normale giorno lavorativo per gli uffici. L’atmosfera a cui siamo generalmente abituati si può percepire già da fine ottobre: decorazioni, luci e musiche natalizie invadono le strade, i negozi e le stazioni.
Photo credits: Condé Nast Traveler
Le origini di Kurisumasu in Giappone
Il cristianesimo fu introdotto in Giappone dai missionari gesuiti e francescani nel XVI secolo. Durante i primi anni del cristianesimo molti cristiani furono arrestati, torturati e uccisi per via del loro credo. Solo nel XVII secolo le chiese ricominciarono a popolarsi e nel XX secolo diversi missionari tornarono in Giappone. Oggi i Cristiani del Sol levante sono circa l’1% della popolazione, e si può affermare che la diffusione delle tradizioni cristiane sia avvenuta sul finire del XX secolo. Il Natale è universalmente riconosciuto come festa per piccoli e grandi anche nel Sol Levante, seppur non considerato nel suo spirito religioso. Visto come un periodo di felicità, è diventata una tradizione irrinunciabile. In particolare, la vigilia di Natale è vista come l’occasione per le coppie innamorate di trascorrere del tempo insieme e scambiarsi regali. Anche le coppie sposate si concedono del tempo per se lasciando i bambini con Ji’i-san e Ba’a-chan (nonno e nonna).
Photo credits: JapanToday
Le Tradizioni di “Kurisumasu”
Oltre allo scambio dei doni visto più come un gesto romantico tra fidanzati, ci sono altre due curiose tradizioni che rendono il 25 dicembre molto particolare in Giappone.
La prima è il Pollo Fritto e la seconda è la Torta di Natale.

Photo credits: Google images
Questo periodo dell’anno è il più fruttuoso per i ristoranti della catena di fast-food KFC (Kentucky Fried Chicken). Qui le persone prenotano il loro pollo fritto in anticipo per il giorno di Natale. Tutto nacque da una campagna pubblicitaria lanciata in tutto paese proprio dalla catena americana negli anni 70: “Kurisumasu ni wa kentakkii!” (Kentucky for Christmas!). KFC se ne servì per attrarre la popolazione orientale offrendo loro un menù completo in confezione natalizia che comprendeva pollo, insalata e torta.

Photo credits: Google images
La Torta di Natale invece è in genere un semplice pan di spagna con panna e fragole decorata a tema natalizio.
Inoltre non è difficile in questo periodo udire le note di Jingle Bells e All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, oltre ad una vasta quantità di canzoni realizzate da gruppi e cantanti giapponesi come Nozomi Sasaki e Momoiro Clover Z.
Japan Folklore: Botan Dōrō
Botan Dōrō
La Lanterna di Peonie
 Photo credits: allabout-japan.com
Photo credits: allabout-japan.com
Esistono molte storie dove amanti sfortunati sono divisi dal destino, a volte arrivando insieme alla morte (Romeo e Giulietta e Tristano ed Isotta le più famose). Ma nessuna è come la storia Botan Dōrō o La lanterna di Peonie (牡丹燈籠). Due innamorati divisi dal regno dei vivi e quello dei morti sono indissolubilmente legati dal loro giuramento d’eterno amore.
Questa leggenda vede la luce nel libro Jiandeng Xinhua scritto da Qu You durante la prima parte della dinastia Ming. Successivamente, venne poi riproposta durante il periodo Edo dallo scrittore e prete buddista Asai Ryōi sull’onda del fenomeno Kaidan (怪談). Questo termine giapponese indica tutte quelle storie che narrano di mistero e fantasmi, scritto con due kanji: Kai( 怪)che significa “strano, misterioso, apparizione incantata” e Dan (談)“narrazione recitata”.
Questa leggenda va riconosciuta come una delle prime storie giapponesi riguardanti i fantasmi a diventare film nel 1910. Con numerose riedizioni durante gli anni, è forse una più produttive tra cinema, adattamenti televisivi e Pink Movie, genere Soft Porno Giapponese.
La bella Otsuyu
 Photo credits: pinterest.com
Photo credits: pinterest.com
La leggenda narra che durante la prima notte dell’ Obon (la commemorazione dei defunti secondo la tradizione Buddista Giapponese) il samurai Ogiwara Shinnojo incontra una bellissima donna e una bambina sua serva. In mano le due hanno lanterne di peonie, come vuole l’usanza, e il samurai chiede alla bimba il nome della splendida donna. Otsuyu era il suo nome ed il samurai non fu in grado di fare altro se non innamorarsene perdutamente e giurarle amore eterno quella sera stessa. Da li in poi, tutte le sere i due si incontrano bruciando di passione l’uno per l’altra. Tuttavia, durante le prime ore del mattino la bella donna e la bambina sparivano. A causa di questo comportamento sospetto, ed anche per via di una malattia improvvisa dell’uomo, un anziano vicino si incuriosisce. Entrando in casa sua, scopre che il samurai non giaceva a letto con una bellissima donna ma con uno scheletro! L’anziano vicino avvisa dunque un prete che a sua volta avvisa Ogiwara, il quale scopre così che l’amata è in realtà un fantasma. Ogiwara capisce anche che la sua malattia era dovuta al fatto che dormire con uno spirito consuma l’energia vitale di una persona. Il prete benedice l’abitazione del samurai lasciando incantesimi protettivi e portafortuna affinché la donna e la bambina non possano più entrare. La sera stessa la donna cerca invano di raggiungere l’amato ma, non riuscendovi, urla disperata il suo amore per Ogiwara che alla fine cede lasciandola entrare in casa. La mattina dopo, il vicino ed il prete trovano Ogiwara morto stringendo a sè lo scheletro di Otsuyu.
Dallo stile macabro del periodo Edo al romanticismo di quello Meiji
 Photo credits: tumblr.com
Photo credits: tumblr.com
Di questa storia è molto famosa la versione del teatro Kabuki, ma c’è una sostanziale differenza tra le due. Nella versioni teatrale infatti i protagonisti si conoscono prima della morte di Otsuyu. Le loro famiglie sono molto vicine da tempo e questo aveva favorito la nascita dell’amore tra i due. Questa versione è la più conosciuta proprio per il romanticismo pregnante dall’inizio alla fine. Il loro amore, la passione giovanile, e poi la delusione per un distacco forzato dovuto per un periodo alla malattia del ragazzo. Durante questo periodo di separazione Otsuyu muore convinta che Saburo non fosse sopravvissuto alla malattia. Saburo invece si riprende e disperato per la morte della ragazza prega il suo spirito durante la festa dell'Obon. Quella sera stessa, tornando a casa, incontra sul suo cammino una donna e la sua serva con in mano una lanterna di peonie. Con sua grande gioia il giovane si accorge che quella donna è proprio la sua Otsuyu che da quella notte in poi, tutte le notti, andrà a fargli visita. Ma la gioia durerà poco. Infatti, un servo, spiando da una fessura nel muro della stanza di Saburo, si accorge che in realtà egli giaceva ogni notte con uno scheletro. Un prete buddista viene subito avvertito e alle porte della casa vengono affissi dei talismani per impedire allo spirito di entrare. Eppure, ogni notte la fanciulla torna per gridare il suo amore per Saburo che, disperato per la nuova separazione, si ammala nuovamente. Ma la consapevolezza di amarla comunque e nonostante tutto significa una sola cosa. La morte! I talismani vengono rimossi per permettere allo spirito di entrare ancora una volta. L’ultima. Il giovane protagonista però muore felice tra le braccia di colei che ama.
Questa differenza di temi si può attribuire al diverso periodo in cui sono state scritte le due versioni. Quella originale risale al periodo Edo con la vena macabra che caratterizza il folclore Giapponese dell’epoca. Quella teatrale invece è più recente e vede la luce nel periodo Meiji, ovvero il periodo in cui il Giappone si avvicina all’occidente grazie all’apertura dell’imperatore Mutsuhito. Apertura che non si verificò solo a livello politico, ma anche a livello culturale influenzando quindi gusti e costumi, e questa leggenda ne è un esempio.
Japan History: I Samurai
I Samurai

Photo credits: focus.it
Il nome Samurai deriva dal verbo saburau che vuol dire "servire" o "tenersi a lato", letteralmente "colui che serve". In giapponese, durante il periodo Heian (794-1185), si pronunciava saburapi e più tardi saburai.
Altro nome con cui era conosciuto il samurai è bushi (武士). Questo termine appare per la prima volta nel Shoku Nihongi (続日本紀, 797 d.C.), un antico documento giapponese racchiuso in quaranta volumi. Esso raccoglie le più importanti decisioni di stato prese dalla corte imperiale tra il 697 d.C. e il 791 d.C. . In una parte del libro si dice: "I samurai sono coloro che formano i valori della nazione".
Secondo il libro Gli ideali del samurai di William Scott Wilson, le parole bushi e samurai sono diventate sinonimi alla fine del XII secolo. Wilson esplora a fondo le origini della parola "guerriero" nella cultura giapponese senza tralasciare i caratteri kanji con cui viene scritto. Egli afferma che bushi in realtà si traduce con "l'uomo che ha la capacità di mantenere la pace, con la forza militare o letteraria".
Saburai è stato sostituito da samurai agli inizi dell'era moderna, alla fine del periodo Azuchi-Momoyama (1573–1603) e agli inizi del periodo Edo del tardo XVI e XVII secolo.

Photo credits: focus.it
I Samurai servivano i daimyō, feudatari locali che rispondevano allo shogun. Quando questo moriva o ne perdeva la fiducia, il samurai diventava Rōnin, ovvero "uomo onda", inteso come "libero da vincoli".
Il bushidō, il codice d'onore dei samurai, prevedeva che per espiare la propria colpa e riacquistare l'onore perduto si dovesse ricorrere alla pratica dello harakiri, che significa "tagliare il ventre" . L’harakiri rappresenta la parte culminante della pratica del suicidio rituale denominato seppuku, attraverso lo sventramento del ventre con la spada corta wakizashi. Il venir meno a questi principi causava il disonore del guerriero che diventava un rōnin appunto, ossia un samurai errante, alla deriva, senza onore né dignità.
Il significato della parola ronin assumeva dunque un carattere dispregiativo, soprattutto nell'era Tokugawa (1603- 1868), l'epoca di massimo isolamento e splendore del Giappone. In questo periodo i ronin giravano per le campagne intimidendo i contadini e saccheggiando villaggi, in cerca di un nuovo signore a cui prestare servizio.
Un rōnin poteva essere disposto a lavorare per chiunque lo pagasse, oppure poteva arrivare a unirsi ad altri come lui e creare scompiglio. Questi guerrieri erano disprezzati dai samurai veri e propri, tant'è che nessuno era chiamato a rispondere della loro uccisione. Ma i ronin avevano anche un altro ruolo. Capitava infatti che si unissero a mercanti, contadini e artigiani per difendere i villaggi dai saccheggi dei briganti, insegnando tecniche di guerra e le arti marziali. Costituivano una sorta di guardia del corpo (yojimbo) auto organizzata.
Si pensa che questa specie di polizia privata possa essere all'origine della yakuza, la moderna mafia giapponese. I suoi affiliati hanno infatti in comune con i samurai un forte senso di appartenenza ai clan e una lealtà assoluta verso il proprio "boss".
Questi sono alcuni termini usati come sinonimo di samurai.
•Buke 武家 - un appartenente a una famiglia militare, un suo membro;
•Mononofu もののふ - termine arcaico per "guerriero";
•Musha 武者 - abbreviazione di bugeisha 武芸者, letteralmente "uomo delle arti marziali";
•Shi 士 - pronuncia sinogiapponese del carattere che comunemente si legge samurai
•Tsuwamono 兵 - termine arcaico per "soldato", reso celebre da un famoso haiku di Matsuo Basho; indica una persona valorosa;

Photo credits: samurai-archives.com
L'addestramento cominciava dai 3 anni, e fino ai 7 consisteva nell’imparare a non temere la morte ed il combattimento, e ad obbedire al proprio signore, controllando la mente ed il corpo. Per temprare il corpo, venivano sottoposti a docce gelate sotto le cascate o nella neve, così che potessero imparare a resistere agli stimoli esterni. Si passava poi all'insegnamento dell'uso dell'arco e della spada contro nemici immaginari.
A 12 anni erano già in grado di uccidere.
Il legame con gli addestratori poteva diventare molto speciale. In epoca feudale le pratiche sessuali tra uomini erano all'ordine del giorno per i guerrieri samurai. Secondo la tradizione dello shudo - da wakashudo (la "Via degli adolescenti") - i giovani trascorrevano diversi anni a contatto con uomini più grandi. Uomini che oltre ad iniziarli alle tecniche di combattimento li introducevano al mondo del sesso. Gli apprendisti samurai ne divenivano allora gli amanti ufficiali, in un rapporto che era riconosciuto ed esigeva, naturalmente, fedeltà assoluta.
I samurai lavoravano per la gloria del daimyō, ma il loro stipendio si limitava a una paga in riso. Per mantenere il proprio status sociale, i samurai che non erano già ricchi di famiglia si arrangiavano come potevano con lavoretti secondari, come la fabbricazione di ombrellini o stuzzicadenti. Li facevano vendere ad altri, però, per non compromettersi troppo. Avevano però anche diversi privilegi: avere un cognome, che la gente comune in Giappone non aveva, e quello del kirisute gomen, ossia l' "autorizzazione a tagliare e abbandonare". Il samurai poteva cioè uccidere chiunque gli avesse mancato di rispetto, se di rango inferiore. L'unico scrupolo era riuscire a dimostrare successivamente, in sede legale, il torto subito.
Per quanto riguarda la vita sentimentale, la moglie dei samurai veniva scelta a tavolino. Essa doveva appartenere a una stirpe guerriera, oppure essere "adottata" da una famiglia di samurai che ne nobilitasse le origini prima del matrimonio. Alle spose dei samurai toccava però un "privilegio" (si fa per dire): col matrimonio guadagnavano il diritto di praticare anch'esse il suicidio rituale, il jigai, con un taglio alla gola.
Nel Giappone medievale si potevano incontrare anche donne samurai addestrate nei valori e nell'arte marziali della casta fin da giovanissima età. I Samurai di questa casta praticavano arti marziali, lo zen, il cha no yu (arte del té) e lo shodō (arte della scrittura). Nell'era Tokugawa persero la loro funziona militare diventando molti di loro semplici rōnin. Alla fine del periodo Edo i samurai erano diventati burocrati al servizio dello shōgun o del daimyō, e la loro spada veniva usata solo per scopi cerimoniali per sottolineare la loro appartenenza alla casta.
Con il rinnovamento Meiji e l’apertura del Giappone al mondo occidentale nel XIX secolo, la classe dei samurai fu abolita poichè ritenuta anacronistica e fuori dal tempo. Al suo posto fu favorito un esercito in stile occidentale. Due leggi, sotto l'Imperatore Meiji (1852-1912), segnarono la fine dei samurai. Una, l'editto Dampatsurei, obbligò i servi guerrieri a rinunciare al codino e a portare i capelli all'occidentale. L'altra, meno di "facciata" e ancora più determinante, fu l'editto Haitorei, che li privò del diritto di portare armi in pubblico. Ai samurai senza katana non rimase che una piccola pensione statale, e il rifugio nel folclore.
Ma il bushidō continua tutt'oggi a sopravvivere nella società Giapponese odierna.
Le Armi
 Photo credits: cdn.history.com
Photo credits: cdn.history.com
I samurai usavano una grande varietà di armi, anzi un'evidente differenza tra la cavalleria europea e i samurai riguarda proprio l'impiego delle armi. I samurai non ritennero mai che esistessero armi disonorevoli, ma solo armi efficienti e inefficienti. L'uso delle armi da fuoco costituì una parziale eccezione, in quanto fu fortemente scoraggiato durante il XVII secolo dagli shogun Tokugawa. Si arrivò a proibirle quasi completamente e ad allontanarle del tutto dalla pratica della maggior parte dei samurai.
Nel periodo Tokugawa si diffuse l'idea che la katana contenesse l'anima del Samurai, e a volte sono stati descritti (erroneamente) come totalmente dipendenti dalla spada per combattere.
Raggiunti i tredici anni, in una cerimonia chiamata genpuku, ai ragazzi della classe militare veniva dato un wakizashi (lo spadino utilizzato anche per suicidarsi) e un nome da adulto. Diventavano così vassalli, cioè samurai a tutti gli effetti. Questo dava loro il diritto di portare una katana, sebbene venisse spesso assicurata e chiusa con dei lacci per evitare sfoderamenti immotivati o accidentali. Insieme, katana e wakizashi, vengono chiamati daishō (letteralmente: "grande e piccolo"). Il loro possesso era la prerogativa del buke, la classe militare al vertice della piramide sociale. Portare le due spade venne vietato nel 1523 dallo shogun ai cittadini comuni che non erano figli di un samurai, per evitare rivolte armate, perché prima della riforma tutti potevano diventare samurai.
Ma oltre alla spada, un’altra importantissima arma dei samurai, era lo shigetou, l'arco asimmetrico giapponese, e ciò non fu modificato per secoli, fino all'introduzione della polvere da sparo e del moschetto nel XVI secolo. Lo shigetou, lungo 2 metri e fatto di legno laminato e laccato,era arma di esclusiva pertinenza dei samurai. Fino alla fine del XIII secolo la via della spada (kendo) fu meno considerata della via dell'arco da molti esperti di bushidō. Un arco giapponese era un'arma molto potente: le sue dimensioni permettevano di lanciare con precisione vari tipi di proiettili (come frecce infuocate o frecce di segnalazione) alla distanza di cento metri. Arrivavano addirittura fino a duecento metri quando non era necessaria la precisione.
Durante l'era di più grande potere dei samurai il termine yumitori (arciere) veniva utilizzato come titolo onorario per un guerriero, anche quando l'arte della spada divenne la più importante. Gli arcieri giapponesi (vedi arte del kyūjutsu) sono ancora fortemente associati con il dio della guerra Hachiman.

Photo credits: nihonjapangiappone.com
L’arco veniva usato solitamente a piedi, dietro un tedate, un largo scudo di legno, ma poteva essere usato anche a cavallo. La pratica di tirare con l'arco da cavallo divenne una cerimonia shinto detta yabusame. Nelle battaglie contro gli invasori mongoli, questi archi furono l'arma decisiva, contrapposti agli archi più piccoli e alle balestre usate dai cinesi e dai mongoli.
Nel XV secolo anche la lancia (yari) divenne un'arma popolare. Lo yari tese a rimpiazzare la naginata allorquando l'eroismo individuale divenne meno importante sui campi di battaglia e le milizie furono maggiormente organizzate. Nelle mani dei fanti o ashigaru divenne più efficace di una katana, soprattutto nelle grosse cariche campali. Nella battaglia di Shizugatake, in cui Shibata Katsuie fu sconfitto da Toyotomi Hideyoshi, i cosiddetti "sette lancieri di Shizugatake" ebbero un ruolo cruciale nella vittoria.
Completavano il corredo i ventagli da guerra con i bordi affilati come coltelli, ma per diverse epoche della storia giapponese i samurai furono i soli a poter portare armi.
Il Seppuku

Photo credits: focus.it
Seppuku (切腹) è un termine giapponese che indica un rituale per il suicidio in uso tra i samurai. In Occidente viene usata più spesso la parola harakiri (腹切り). A volte in italiano viene erroneamente pronunciato come "karakiri", con pronuncia e scrittura errata dell'ideogramma hara.
Nello specifico seppuku e harakiri presentano alcune differenze, qui di seguito spiegate.
La traduzione letterale del termine seppuku è "taglio dello stomaco", mentre per harakiri è "taglio del ventre" e veniva eseguito secondo un rituale rigidamente codificato. Esso era un modo per espiare una colpa commessa o un mezzo per sfuggire a una morte disonorevole per mano dei nemici. Un elemento fondamentale per la comprensione di questo rituale è il seguente: si riteneva che il ventre fosse la sede dell'anima.Il significato simbolico di questo atto era dunque quello di mostrare agli astanti la propria anima priva di colpe in tutta la sua purezza. Ma anche l'estremo gesto di orgoglio e libertà di un samurai seguiva regole rigidamente codificate. Il sacrificio si doveva consumare davanti a testimoni utilizzando il pugnale (tantō) o la spada corta (wakizashi) ed eseguendo un taglio a "L", che partiva dall'ombelico e si allungava da sinistra a destra, e poi verso l'alto.
I piedi con le punte rivolte verso il basso garantivano che il moribondo seduto sulle ginocchia cadesse in avanti, coprendo lo scempio di sangue e budella. La presenza di testimoni e del kaishakunin, l'assistente incaricato di finire il ferito con un colpo di katana al collo, assicurava che la vittima non soffrisse ulteriormente (e non avesse ripensamenti).
Il kaishakunin era un fidato compagno del samurai che, previa promessa all'amico, lo decapitava appena egli si era inferto la ferita all'addome, per fare in modo che il dolore non gli sfigurasse il volto e preservandone l’onore.
Alcune volte praticato volontariamente per svariati motivi, durante il periodo Edo (1604–1867) divenne una condanna a morte che non comportava disonore. Infatti il condannato, vista la sua posizione nella casta militare, non veniva giustiziato, ma invitato o costretto a togliersi da solo la vita praticandosi con un pugnale una ferita profonda all'addome di una gravità tale da provocarne la morte.
La decapitazione (kaishaku) richiedeva eccezionale abilità e infatti il kaishakunin era l'amico più abile nel maneggio della spada. Un errore derivante da poca abilità o emozione avrebbe infatti causato notevoli ulteriori sofferenze. Proprio l'intervento del kaishakunin e la conseguente decapitazione costituiscono la differenza essenziale tra seppuku e harakiri. Infatti, sebbene le modalità di taglio del ventre siano analoghe, nell'harakiri non è prevista la decapitazione del suicida. Viene pertanto a mancare tutta la relativa parte del rituale, con conseguente minore solennità dell'evento.
Il più noto caso di seppuku collettivo è quello dei "quarantasette rōnin", celebrato nel dramma Chushingura, mentre il più recente è quello dello scrittore Yukio Mishima avvenuto nel 1970. In quest'ultimo caso, il kaishakunin Masakatsu Morita, in preda all'emozione, sbagliò ripetutamente il colpo di grazia, e ciò richiese l’intervento di Hiroyasu Koga, che decapitò lo scrittore.
Una delle descrizioni più accurate di un seppuku è quella contenuta nel libro Tales of Old Japan (1871) di Algernon Bertram Mitford, ripresa in seguito da Inazo Nitobe nel suo libro Bushido, L'anima del Giappone (1899).
Nel 1889, con l’introduzione della costituzione Meiji, venne abolito come forma di punizione ma casi di seppuku si ebbero al termine della seconda guerra mondiale tra gli ufficiali, spesso provenienti dalla casta dei samurai, che non accettarono la resa del Giappone. Un caso celebre fu quello dell'anziano ex daimyō Nogi Maresuke che si suicidò nel 1912 alla notizia della morte dell'imperatore.
Con il nome di jigai, il seppuku era previsto, nella tradizione della casta dei samurai, anche per le donne. In questo caso il taglio non avveniva al ventre bensì alla gola, dopo essersi legate i piedi per non assumere posizioni scomposte durante l'agonia.
L'arma usata poteva essere il tantō (coltello), anche se più spesso, soprattutto sul campo di battaglia, la scelta ricadeva sul wakizashi, detto per questo "guardiano dell'onore".

Photo credits: wikipedia.org
Il Bushidō
Il guerriero giapponese viveva e moriva secondo un rigido codice di comportamento, il bushidō (la via del guerriero), che regolava il rapporto unico e inscindibile tra il samurai e il suo daimyō. Alla base di questo codice c'era la fedeltà assoluta, una rigida definizione di onore e il sacrificio del bene del singolo in favore del benessere comune. È questa l'etica alla base delle azioni anche dei kamikaze giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale e di cui si avvertono strascichi in alcune aziende nipponiche moderne.
Qualora un'offesa o una grave colpa avesse incrinato questo rapporto, c'era sempre una via per salvare l'onore: il seppuku o harakiri, il suicidio rituale.
I precetti dei samurai furono pesantemente influenzati dalle principali correnti spirituali e culturali giapponesi. Verso il 1000 era ancora lo shintoismo la principale fonte di ispirazione per i samurai, corrente che sottolineava la fedeltà all'imperatore, in un'epoca in cui essere samurai voleva dire essere un guerriero abile. Successivamente però concetti taoisti, buddisti e confuciani iniziarono a diffondersi e a sovrapporsi tra lori. In particolare ebbero grande fortuna, dopo il buddismo cinese, il buddismo zen e il buddismo esoterico. Quest'ultimo era praticato soprattutto nelle casate nobili più ricche e potenti, mentre il buddismo zen era praticato anche a livello di piccole scuole e fra i rōnin. In quest'epoca si diffusero molte scuole che associavano ai doveri del samurai l'obbligo di svolgere i propri compiti non solo al massimo delle proprie capacità, ma anche con grazia ed eleganza. Ciò voleva dire dimostrare attraverso il gesto la propria superiorità. Questa pratica che fu molto contestata nel XVI secolo, è rimasta in molte scuole di pensiero samurai.
I guerrieri del 900 erano divenuti, prima del 1300, raffinati poeti, mecenati, pittori, cultori delle arti, collezionisti di porcellane, codificando in molte opere di bushido (fino al Libro dei cinque anelli) una precisa necessità. Un samurai doveva infatti essere esperto in molte arti, non solo in quella della spada. La prima grande codificazione di questa svolta avvenne nello Heike Monogatari, opera letteraria più famosa del periodo Kamakura (1185-1249). Quest’opera attribuiva alla via del guerriero l'obbligo dell'equilibrio tra la forza militare e la potenza culturale. Gli eroi di questa epopea (la storia di una lotta tra due clan, i Taira e i Minamoto) e di altre che si ispirarono a questa negli anni immediatamente successivi, sono gentili, ben vestiti, molto attenti all'igiene, cortesi con il nemico nei momenti di tregua. Ma erano anche abili musicisti, competenti poeti, letterati talvolta particolarmente versati nella calligrafia o nella disposizione dei fiori. E ancora, era appassionati cultori del giardinaggio e spesso interessati alla letteratura cinese.
Inoltre, morendo, spesso mettevano in versi il proprio epitaffio.
Questa visione duplice dei compiti del samurai si affermò grandemente, fino a diventare egemonica. Hojo Nagauji (o Soun), signore di Odawara (1432-1519), uno dei più importanti samurai della sua epoca scrisse nei Ventuno precetti del samurai: "La via del guerriero deve sempre essere sia culturale, sia marziale. Non è necessario ricordare che l'antica legge stabilisce che le arti culturali dovrebbero essere rette con la sinistra e quelle marziali con la destra". In questo egli sottolineava una certa predominanza per le arti marziali, ma da questo insegnamento trassero spunto numerosi samurai che divennero famosi tanto come spadaccini, quanto, e più, come esperti della cerimonia del tè, o come artisti, attori di teatro Nō e poeti. Imagawa Royshun (1325-1420), grande commentatore dell'arte della guerra di Sun Tzu, nelle sue Norme si era spinto oltre, affermando che "Senza conoscere la via della cultura, non ti sarà possibile raggiungere la vittoria in quella marziale". Royshun aveva così creato un nuovo concetto di equilibrio tra cultura e guerra noto come bunbu ryodo ("non abbandonare mai le due vie").
Lo stesso Miyamoto Musashi, uno dei più grandi duellisti del XVII secolo, divenne nella seconda parte della sua vita uno dei più grandi pittori di quel periodo. Concordava con Takeda Shingen (1521-1573), forse il più brillante generale del XVI secolo, che affermava come la grandezza di un uomo dipendeva dalla pratica di numerose vie.
Questo atteggiamento ovviamente provocò tutta una serie di aspre critiche. In particolare si ricorda l'avversione di Kato Kiyomasa (1562-1611) per tutto ciò che non era marziale e la sua opinione, condivisa da molte scuole "estremamente marziali", era che un samurai dedito alla poesia sarebbe divenuto "effeminato", mentre un samurai che avesse praticato il mestiere dell'attore o si fosse interessato al teatro Nō avrebbe dovuto suicidarsi per il disonore che arrecava al suo nome. Correnti di pensiero "estremamente marziali" e di rifiuto degli aspetti culturali della figura del samurai si diffusero notevolmente nei secoli successivi. Questo fatto potrebbe sembrare paradossale per un'epoca di pace (la cosiddetta Pax Tokugawa) durante la quale in piccoli dojo non solo si accettava l'etichetta, ma anzi la si studiava a fond. Al contempo però si intendeva anche ritornare al significato originario dell'essere samurai, il guerriero impavido.
Le differenti fonti di ispirazione culturale a cui erano soggetti i samurai (scintoismo, scintoismo esoterico, taoismo, buddismo cinese, buddismo della terra pura, buddismo zen, buddismo esoterico, confucianesimo ufficiale cinese, confucianesimo dei glossatori giapponesi ed epica classica giapponese) crearono scuole di pensiero e di pratica molto differenti.I principi di vita seguiti erano talvolta contrapposti o, più spesso, semplicemente complementari, anche grazie alla grande attitudine al pragmatismo e al sincretismo della cultura giapponese.

Photo credits: wikipedia.org
Simbolo di tutte le arti marziali. Nell'iconografia classica del guerriero il ciliegio rappresenta insieme la bellezza e la caducità della vita, ed era per questo venerato.I sakura, durante la fioritura, mostrano uno spettacolo incantevole nel quale il samurai vedeva riflessa la grandiosità della propria figura avvolta nell'armatura. Ma è sufficiente un improvviso temporale perché tutti i fiori cadano a terra, proprio come il samurai può cadere per un colpo di spada infertogli dal nemico. Il guerriero, abituato a pensare alla morte in battaglia non come un fatto negativo ma come l'unica maniera onorevole di andarsene, rifletté nel fiore di ciliegio questa filosofia.
Un antico verso ancora oggi ricordato è "tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero" (花は桜木人は武士 hana wa sakuragi, hito wa bushi), ovvero "come il fiore del ciliegio è il migliore tra i fiori, così il guerriero è il migliore tra gli uomini".
SalvaSalva
Japanese Culture: Il Ramen
Ramen: “Imperatore” della tavola Giapponese.

Photo credits: narutonoodle.com/
Fino a pochi anni fa, per amanti o meno della cucina etnica, andare al Giapponese equivaleva prettamente a gustare Sushi: piatto composto da pesce crudo e riso.
Questo piatto da colori e forme suggestive strizza l’occhio ai commensali più modaioli (ma non solo!), che hanno modo di gustare “prima con gli occhi che con la gola”. Ma ora un altro piatto famoso in tutto il Giappone è finalmente approdato anche sulle nostre tavole, facendo impazzire i più.
Il Ramen (ラーメン,拉麺 rāmen), forse vero e proprio piatto rappresentativo del paese. Talmente conosciuto in tutto il Giappone che vanta per ogni regione un suo modo diverso di farlo. Regione diversa, ricetta diversa. Gustiamole tutte allora …
Una zuppa ricca di ingredienti: spaghetti cinesi, carne di maiale, Nori (海苔) o alga secca, uova sode, e il kamaboko. Da noi conosciuto come surimi, la sua forma più famosa, quella a spirale, si chiama Naruto (come il personaggio del manga omonimo il cui nome è ispirato proprio a questo ingrediente) . Il brodo può essere di pesce o carne, varie guarnizioni e modi diversi di insaporire, con semi di sesamo o pepe, dal miso alla salsa di soia.
Storia di una Zuppa

Photo credits: travelcaffeine.com
Benché non sia chiaro quando ebbe inizio la diffusione di questo piatto in suolo giapponese, l’origine è cinese, visto che uno degli ingredienti base sono i mian o spaghetti cinesi di frumento. Va anche detto che in Cina solo negli ultimi anni c’è stata una riscoperta, non considerato più piatto tradizionale ma d’importazione giapponese. In Cina vengono chiamati rìshì lāmiàn “Lamian in stile Giapponese”.
Il Ramen è sempre stato un piatto da gustare fuori casa, e all’inizio del ‘900 c’erano numerosi chioschi da strada con gestori Cinesi. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i soldati giapponesi di rientro dalla Cina, dove avevano appreso la tradizione culinaria, aprirono diversi ristoranti in tutto il paese. Da lì in poi, una continua evoluzione che ha portato a come si conosce il Ramen oggi giorno.
Così tanto amato che dal 1994 è stato aperto a Yokohama lo Shin-Yokohama Raumen Museum il museo interamente dedicato a questa prelibatezza.
Ramen da compagnia.

Photo credits: jpninfo.com
Come detto in precedenza, in passato non era poi così strano gustare scodelle di Ramen nei chioschi da strada, famosi anche oggi giorno sebbene non diffusissimi. Questo perché il Ramen è anche un cibo da strada da assaporare nei tradizionali Yatai, bancarelle mobili. I migliori ristoranti invece sono i Ramen-ya con pochi posti a sedere sia al banco che ai tavoli, ma con la finalità di mangiare solo Ramen.
E non è inusuale trovare piatti di Ramen in parchi divertimento o nei menù dei karaoke. Ci scappa anche che finito il lavoro tra colleghi si faccia un salto agli Izakaya, pub con la formula Nomihodai “all you can drink” e Tabehodai “all you can eat”. Qui, con un tempo massimo di tre ore, i commensali tra liquori ed altri cibi possono gustare anche il Ramen con un menù dal prezzo fisso.
Menzioni d’onore e le regionali.

Photo credits: zerochan.net
Benché la ricetta classica sia comune in tutto il Giappone ci sono varianti sempre innovative.
Qui va menzionato il Ramen Blue , di un bellissimo e brillantissimo colore, e vogliamo anche dirlo del tutto naturale! Ma questa è un'innovazione estrema.
Le varianti “classiche” regionali sono:
- Quella di Tokyo con tagliatelle spesse in brodo di pollo al gusto soia, con guarnizione di germogli di bamboo, scalogno, maiale a fette, spinaci alghe, un uovo e un po’ di Dashi. Da provare nei quartieri di Ikebukuro, Ogikubo e Ebisu.
- A Sapporo è famosa per la versione “invernale”, con talvolta frutti di mare, burro, maiale, mais e germogli di fagioli.
- Yokohama ha il le-kei , uovo alla coque dove il commensale deve indicare la morbidezza desiderata per poi romperlo ed insaporire il brodo con cipolla, maiale, spinaci e alga.
- Kitakata con tagliatelle spesse ma piatte, servite in brodo di maiale.
- Hakata con brodo composto da osso di maiale, e con spaghetti sottili, zenzero, aglio, verdure in senape e semi di sesamo.
Se leggendo questo articolo vi è venuta una gran fame vogliamo lasciarvi alcuni indirizzi dove poterlo gustare qui in Italia:
Nozomi
Via Pietro Calvi 2, 20129 Milano, Italia
+39 02 7602 3197
http://www.nozomi.milano.it/
Casa Ramen
Via Porro Lambertenghi 25, Milano, Italia
+39 02 3944 4560
https://www.facebook.com/casaramen
Zarà Ramen
Via Solferino, 48, 20121 Milano, Italia
+39 02 3679 9000
https://www.facebook.com/zazaramen/
Mi-Ramen Bistro
Viale col di lana, 15 | Viale Col Di Lana, 15, 20136, Milano
+39 339 232 2656
http://mi-ramenbistro.it/
Osaka
Corso Giuseppe Garibaldi 68, 20121 Milano, Italia
+39 02 2906 0678
http://www.milanoosaka.com/
Ryukishin
Via Ariberto 1, 20123 Milano, Italia
+39 02 8940 8866
http://www.ryukishin.it/
Banki Ramen
Via Dei Banchi 14 Rosso, 50123, Firenze, Italia
+39 055 213776
Waraku
Via Prenestina 321/A, 00177 Roma, Italia
+39 06 2170 2358
https://www.facebook.com/Waraku-192626757583758/
Japan History: Minamoto no Yoshitsune
Minamoto no Yoshitsune
 Photo credits: wikipedia.org
Photo credits: wikipedia.org
Minamoto no Yoshitsune (1159-1189) era il nono figlio di Minamoto no Yoshitomo (1123-1160), ed il terzo figlio avuto con Tokiwa Gozen. Nome d'infanzia di Yoshitsune era Ushiwakamaru (牛若丸). Poco dopo la sua nascita, scoppiò la ribellione di Heiji, nella quale suo padre e i suoi due fratelli più grandi persero la vita. Mentre suo fratello maggiore Yoritomo, ormai erede designato del clan, fu esiliato nella provincia di Izu, Yoshitsune fu affidato al tempio di Kurama, sulle montagne di Hiei, vicino Kyoto. Fu infine preso in custodia da Fujiwara no Hidehira (藤原秀衡?), capo del potente ramo settentrionale del clan Fujiwara (Fujiwara del Nord), e portato a Hiraizumi, nella provincia di Mutsu.
 Photo credits: wikimedia.org
Photo credits: wikimedia.org
Nel maggio 1180, il figlio dell'imperatore Go-Shirakawa appoggiato dal clan Minamoto, scrisse una dichiarazione per spingere i Minamoto a sollevarsi contro i Taira. Il contesto è quello della guerra Genpei (1180–1185) che vide contrapposti i clan Taira e Minamoto sulla scelta dell'imperatore da porre sul trono e così assicurarsi il controllo del Paese. La battaglia di Uji fu l'inizio di una guerra che durò 5 anni, e durante la quale Yoshitsune e Yoritomo si riunirono dopo la loro separazione avvenuta nel 1160.
Nel 1184 Yoshitsune andò contro suo cugino Yoshinaka. Quest’ultimo aveva preso il controllo dei Minamoto dopo aver sconfitto i Taira nel Giugno del 1183. A quel punto, Yoritomo mandò contro Yoshinaka suo fratello Yoshitsune che nello stesso anno ottenne la carica di Sô-daisho (generale dell'armata). Le truppe di Yoshinaka furono sconfitte e non appena lo stesso lo venne a sapere, abbandonò Kyoto insieme a Tomoe Gozen, unico esempio di samurai donna. Fu poi messo alle strette a Awazu e costretto a suicidarsi.
Senza più Yoshinaka, Yoritomo ottenne il supporto di Go-Shirakawa per continuare la guerra contro i Taira. Il 13 marzo Yoshitsune si spostò a Settsu, ed il suo primo obiettivo fu una fortificazione dei Taira, Ichi no tani.
Yoshitsune guidò in battaglia 10.000 uomini attaccando da Ovest, mentre 50.000 uomini guidati da Noriyori, fratello di Yoshitomo, attaccavano da est. Il 18 Marzo Yoshitsune arrivò a Mikusayama, attaccando di notte. Secondo lo Heike Monogatari i difensori rimasti vivi scapparono verso la costa rifugiandosi poi nello Shikoku, lasciando 500 morti. Allora Yoshitsune mandò 7000 uomini guidati da Doi Sanehira dal lato ovest verso Ichi no tani, mentre lui stesso ne guidava altri 3000 dalla cima delle scogliere. I Minamoto vinsero sui Taira, e la loro vittoria fece spazio ad un altro assalto a Yashima, il quartier generale dei Taira nello Shikoku. Yoritomo decise per un approccio cauto. I sei mesi successivi furono spesi a consolidare i guadagni già ottenuti e per mettere in ordine le numerose famiglie che avevano finora sostenuto i Minamoto.
Dopo Ichi no tani, Yoshitsune e Noriyori tornarono a Kyoto mostrando per le strade le teste dei Taira. Nell'ottobre successivo Noriyori fu mandato a distruggere i sostenitori dei Taira nel Kyushu e iniziò una lunga e faticosa marcia attraverso le province occidentali. Yoshitsune rimase a Kyoto e agì come il vice di Yoritomo fino ai primi del 1185. Ufficialmente, Yoshitsune era responsabile di emanare decreti che ordinavano la cessazione di qualsiasi violenza all'interno del territorio dei Minamoto. In pratica, le sue direttive riguardavano altri temi, tra cui la proibizione di tasse di guerra senza il consenso espresso della leadership dei Minamoto.
Durante il periodo di Yoshitsune a Kyoto ci furono i primi segni della rottura con Yoritomo. Sembra infatti che quest'ultimo avesse negato a Yoshitsune i titoli imperiali che la corte voleva concedergli, e che si infuriò quando nonostante il suo diniego gli vennero comunque riconosciuti.
Nel Marzo 1185, con Noriyori pronto ad invadere il Kyushu, Yoshitsune fu autorizzato al rientro in guerra. Volendo assaltare Yashima, assemblò una flotta a Watanabe. Durante i preparativi litigò con Kajiwara Kagetoki, uno dei servitori di suo fratello maggiore, riguardo la strategia da adottare, ma nella notte del 22 Marzo Yoshitsune ordinò ai suoi uomini di salpare. Siccome il tempo era brutto, molti uomini rifiutarono di salire sulle navi, ma lo fecero nel momento in cui Yoshitsune minacciò di uccidere chiunque avesse disobbedito ai suoi ordini. Nonostante questo, non tutte le navi lo seguirono.
Yoshitsune arrivò all'alba nello Shukoku, per poi partire per Yashima. La base dei Taira era situata sulla spiaggia e Taira Munemori, accortosi dei fuochi che gli uomini di Yoshitsune avevano acceso nelle vicinanze, ordinò l'immediata evacuazione della fortezza. Lui stesso scappò in nave con Antoku, l’imperatore bambino protetto dai Taira . Nonostante tutto, il clan Taira fu completamente sradicato in quella che viene ricordata come la battaglia di Dan-no-ura, una delle più importanti della storia giapponese.
Dopo la vittoria, nel 1192 a Yoritomo fu dato il il titolo di Shogun. Ma in quell’anno Yoshitsune era ormai già morto perchè Dan-no-ura segnò non solo la consacrazione della sua fama e abilità, ma anche la sua tragica fine.
Da tempo infatti i rapporti con il fratello erano turbolenti. E probabilmente anche la gelosia per l'abilità dimostrata fino ad allora da Yoshitsune ebbe un ruolo nella scelta di Yoritomo di dichiarare il fratello una minaccia per i Minamoto e per l'Impero stesso.

Photo credits: wikimedia.org
Dopo aver tentato di opporsi a Yoritomo, Yoshitsune fu costretto a trovare rifugio a Mutsu, dove si trovava il suo vecchio guardiano Fujiwara Hidehira. Hideara però morì nel Novembre 1187 lasciando come sua ultima volontà una dichiarazione in cui si affermava che Yoshitsune sarebbe dovuto diventare governatore di Mutsu. Un desiderio che il figlio di Hidehira, Yasuhira, ignorò completamente. Scoppiò un inevitabile conflitto con i Fujiwara e le autorità di Kamakura scoprirono dove Yoshitsune si rifugiava.
Benkei, servitore e fedele compagno di Yoshitsune, fece in modo di trattenere i loro assalitori, dandogli così il tempo di uccidere la sua giovane moglie e commettere suicidio. La testa di Yoshitsune fu trasportata a Kamakura, creando una forte emozione in chi la vide.
Venne sepolto nel tempio shintoista di Shirahata Jinja, a Fujisawa, dove la sua salma è tuttora custodita.
Miti e leggende
Nonostante tutto, le notizie riguardanti la morte di Yoshitsune sono sempre state un po' elusive. Secondo l'Ainu historical accounts, non fece seppuku, scappò a Koromogawa, assumendo il nome di Okikurumi/Oinakamui.
A Hokkaido, il tempio di Yoshitsune è eretto in suo onore nella città di Biratori. Alcune teorie lo vedono scappare da Hokkaido e risorgere come Genghis Khan. Ma ovviamente si tratta solo di leggende

Photo credits: samurai-archives.com
Un grande soldato ed una figura classica tragica, Yoshitsune divenne una leggenda ben prima della sua morte. Kujô Kanezane, un supporter di Yoritomo, ha scritto sul suo diario nel 1185,
"Yoshitsune ha lasciato grandi successi; su questo non c'è niente da dire. In coraggio, benevolenza, e giustizia, lascerà una grande eredità ai posteri. In questo può essere solo lodato ed ammirato. L'unica cosa è che ha deciso di andare contro Yoritomo. Questo è un crimine da traditore."
Il modo in cui Yoshitsune morì, gli assicurò un posto d'onore nel futuro, mentre il ricordo di Yoritomo porterà per sempre una macchia nera. Cosa accadde in quell'estate del 1185 sarà sempre un mistero. E’ certo però che i successi di Yoshitsune nella guerra Genpei hanno cambiato il corso della storia giapponese e gli ha assicurato il posto tra i più grandi Samurai.
La vita di Yoshitsune nella letteratura e nell’era moderna
La vita di Yoshitsune, nonostante il suo eccezionale talento militare, finì con una morte cruenta, che attira la compassione di molti. Nella lingua giapponese l'espressione Hougan'biiki (判官贔屓), che vuol dire "compatire o accogliere nelle proprie grazie un debole", contiene il nome postumo di Yoshitsune, Hougan (判官) appunto. Questo nome gli spettava grazie al rango affidatogli dall'imperatore Go Shirakawa, infatti un'altra pronuncia degli ideogrammi di Hougan è Hangan, che significa "magistrato". Inoltre, la vita di Yoshitsune è considerata eroica al punto da essere narrata. Le leggende e i racconti con questo tema si sono moltiplicate col tempo, delineando così una figura di Yoshitsune piuttosto lontana da quella storica. Tra le varie leggende è famosa quella del suo incontro a Oobashi con il fortissimo Musashi. O quella in cui, grazie all'aiuto della figlia dello stregone Kiichi Hogen, riuscì a rubare i due leggendari volumi di tattiche belliche Rikuto e Sanryaku, e a studiarli. O ancora quella dell'improvvisa morte in piedi di Benkei, monaco guerriero, fedelissimo servitore e amico di Yoshitsune, nella battaglia del fiume Koromogawa. Queste leggende sono state rese famose presso un vasto pubblico circa duecento anni dopo la morte di Yoshitsune, all'inizio dell'era Muromachi, grazie alle "Cronache di Yoshitsune". Yoshitsune infatti compare come protagonista nella terza sezione dell'Heike Monotogari, il classico della letteratura giapponese che racconta degli eventi della guerra Genpei e che ispirò molte opere posteriori, soprattutto di teatro Nō e Kabuki. In particolare, si narra che l'aver studiato il "Libro della Tigre", contenuto nel Rikuto, sia stato la causa della sua vittoria a Sunaga, e che da quel momento, esso si sia rivelato indispensabile per le vittorie seguenti. In epoche successive, il nome di Yoshitsune venne utilizzato per consacrare la gloria di una discendenza. Ad esempio, esiste una scuola di arti marziali che avrebbe ereditato delle tecniche da Yoshitsune stesso o da quello che viene ritenuto il suo maestro, Kiichi Hogen.
MOON SAGA e MOON SAGA 2
La figura di Yoshitsune è stata ripresa anche dal cantante e attore giapponese GACKT nelle rappresentazioni teatrali MOON SAGA e MOON SAGA 2. Lui stesso interpreta Yoshitsune descrivendolo come un mononofu, ovvero un essere metà umano metà demone. GACKT, con le sue eccezionali capacità interpretative, è riuscito perfettamente ad interpretare questa dualità, dando vita nella prima parte ad un personaggio ironico, divertente ed anche un po’ impacciato che nella seconda parte diventa demoniaco, spaventoso. Le avventure di Yoshitsune sono, in questo caso, romanzate e rese anche un po' sovrannaturali, ma raccontano comunque la sua storia, perchè Yoshitsune era così. Una dualità, un personaggio pieno di contrasti in cui la benevolenza si alternava con la crudeltà. Yoshitsune perdeva, probabilmente, completamente il controllo quando si sentiva in pericolo e per questo faceva uscire il suo lato "demone".
MOON SAGA 2 è stata anche la prima rappresentazione teatrale al mondo ad usare il projection mapping.

Photo credits: gackt.com

Photo credits: gackt.com